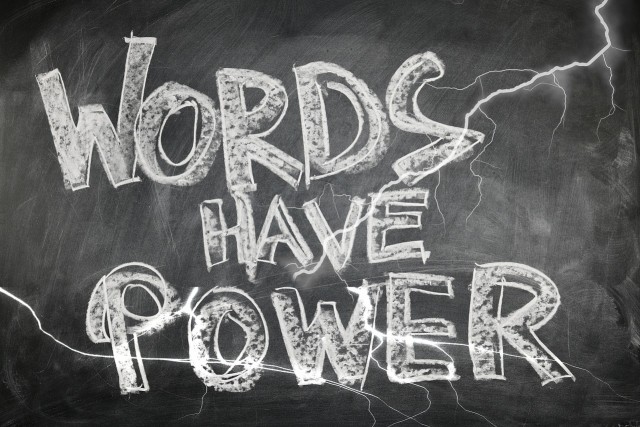Ancora oggi, nonostante i tanti passi avanti, risulta spesso difficile parlare di disabilità. Quando si affronta questo tema, ci si trova di fronte ad imbarazzo, disagio, quasi che, anche solo pronunciando “quella” parola, si potesse attrarre su di sé la sfortuna.
Per secoli, è stata opinione diffusa che la disabilità (e la malattia in genere) fosse legata ad una “colpa” di chi ne era affetto, una sorta di stigma per indicare qualcuno da cui stare alla larga. Ne derivava la pressoché completa emarginazione sociale delle persone disabili, nascoste dai familiari (o allontanate da casa), come se si trattasse di una “macchia” da nascondere agli occhi della società.
Oggi, per fortuna, questo pregiudizio è in gran parte superato, almeno nei Paesi più culturalmente ed economicamente avanzati (e non è un caso che le due cose procedano di pari passo, in genere): ci sono leggi che garantiscono alle persone con disabilità pari dignità e diritti in ogni ambito, dal lavoro alla sfera più privata e personale, e cresce la sensibilità verso temi come l’accessibilità e la necessità d’investire risorse importanti su di essa per il bene di tutta la collettività.
Tuttavia, persistono abitudini scorrette, e spesso offensive (anche involontariamente), quando si tratta di parlare di disabilità o, ancora di più, rapportarsi con una persona affetta da una disabilità, motoria, sensoriale o psichica. Pietà (non nel senso “alto” della pietas di virgiliana memoria), disagio, domande inopportune anche da perfetti estranei (“Che cos’hai esattamente?”, “Perché cammini così?”, “Non puoi fare niente per…?”) , tendenza a considerare la persona disabile alla stregua di un bambino, anche se si tratta di un adulto. Ma anche leggerezza, abitudine ad utilizzare termini associati ad una condizione di disabilità(“handicappato”, “spastico”, “mongoloide” e via discorrendo) come insulti, offese alle facoltà fisiche o cognitive del prossimo o a considerare una persona con disabilità motoria o sensoriale necessariamente “ritardata” (riecco l’offesa…) o, comunque, non proprio con tutte le rotelle a posto.
Come superare tutto questo ed affermare una corretta visione, una vera e propria cultura della disabilità? Le prime risposte che mi vengono in mente sono due: scuola e media.
 I bambini sono, per natura, inclini a non discriminare i “diversi”, a meno che un adulto di cui si fidano insegni loro a farlo: è capitato a tutti di vedere bambini appartenenti a culture, razze, condizioni diverse giocare tra loro senza crearsi alcun problema, perché quello che vedono nell’altro è, semplicemente, un compagno di giochi, non uno straniero, uno di un altro colore, o un disabile. E’ essenziale che la scuola contribuisca a rafforzare questa tendenza innata all’inclusione, favorendo e incoraggiando lo scambio continuo, la convivenza e la condivisione tra bambini normodotati e disabili.
I bambini sono, per natura, inclini a non discriminare i “diversi”, a meno che un adulto di cui si fidano insegni loro a farlo: è capitato a tutti di vedere bambini appartenenti a culture, razze, condizioni diverse giocare tra loro senza crearsi alcun problema, perché quello che vedono nell’altro è, semplicemente, un compagno di giochi, non uno straniero, uno di un altro colore, o un disabile. E’ essenziale che la scuola contribuisca a rafforzare questa tendenza innata all’inclusione, favorendo e incoraggiando lo scambio continuo, la convivenza e la condivisione tra bambini normodotati e disabili.
 Ma anche i mass media possono e debbono svolgere un ruolo importante nel consolidamento della cultura della disabilità. In che modo? Innanzitutto, utilizzando terminologia e modi corretti per parlare di disabilità: meno “tv del dolore” e disabili esibiti come macchiette o fenomeni da baraccone, più disabili nelle trasmissioni (anche come presentatori, oltre che come ospiti o pubblico, perché no?), nei film, nella pubblicità, sulle copertine delle riviste patinate e nelle serie tv. Non necessariamente come gli “infelici”, gli “eroi” di turno. E neanche come i “buoni” per definizione. Non è affatto detto che una persona disabile sia buona, generosa, disponibile con tutti, più saggia o, in una parola, migliore di una non disabile. I disabili, così come tutti, possono essere anche “stronzi”, cattivi, vendicativi, egoisti e quant’altro.
Ma anche i mass media possono e debbono svolgere un ruolo importante nel consolidamento della cultura della disabilità. In che modo? Innanzitutto, utilizzando terminologia e modi corretti per parlare di disabilità: meno “tv del dolore” e disabili esibiti come macchiette o fenomeni da baraccone, più disabili nelle trasmissioni (anche come presentatori, oltre che come ospiti o pubblico, perché no?), nei film, nella pubblicità, sulle copertine delle riviste patinate e nelle serie tv. Non necessariamente come gli “infelici”, gli “eroi” di turno. E neanche come i “buoni” per definizione. Non è affatto detto che una persona disabile sia buona, generosa, disponibile con tutti, più saggia o, in una parola, migliore di una non disabile. I disabili, così come tutti, possono essere anche “stronzi”, cattivi, vendicativi, egoisti e quant’altro.
Semplicemente perché i disabili sono (siamo) persone, con pregi e difetti, come tutti. Persone che convivono con una condizione particolare, certo. Ma persone, non esseri superiori, né inferiori.